(fonte: CARLO STAGNARO PER IL SOLE 24 ORE)
La guerra dell’acqua non è per il controllo delle risorse: è un conflitto commerciale. Da un lato la Coop, secondo cui il consumo di minerale è ecologicamente scorretto. Dall’altro Mineracqua, l’associazione dei produttori, risponde che l’acqua in bottiglia «può avere proprietà favorevoli per la salute».
A prima vista, si tratta di uno scontro anomalo. L’acqua in bottiglia non è in diretta competizione con quella del rubinetto. Le caratteristiche così diverse di questi due beni (a partire dal prezzo) lasciano intendere che intercettano domande differenti. La domanda vera, allora, è: cosa c’è dietro? Con 195 litri a testa, gli italiani sono i primi in Europa e i terzi al mondo (dopo i messicani e gli arabi degli Emirati) per consumo pro capite di minerale. Il confronto tra la principale catena di distribuzione e i produttori di acqua in bottiglia è, insomma, molto concreto. Coop spera di convincere i suoi clienti ad acquistare bottiglie a suo marchio, riempite presso fonti collocate in modo strategico per ridurre i costi di trasporto, ma stima un calo di vendite di circa il 10 per cento. Perché un’azienda dovrebbe consapevolmente perseguire una riduzione dei profitti?
La chiave sta nel presunto effetto reputazionale: e ciò a dispetto del reale fondamento di quella stessa comunicazione verde che, per quanti pregi possa avere, difficilmente riesce a ridurre argomenti complessi a un mero discrimine tra comportamenti buoni e cattivi. Del resto, le emissioni dovute a trasporto, produzione e smaltimento delle bottiglie sono una quota minima del totale. L’estrazione dell’acqua dal sottosuolo è strettamente regolamentata proprio per garantire la conservazione delle falde. Non siamo, insomma, di fronte a quella devastazione che uno si aspetterebbe. Perfino sul fronte sanitario, l’acqua minerale deve rispettare criteri rigidissimi: o è pura, oppure non può essere venduta, punto. Ne segue, tra l’altro, che i produttori tendono a vigilare per prevenire, o scongiurare, qualunque forma di infiltrazione o inquinamento.
È un classico esempio di come l’interesse privato possa allinearsi all’interesse collettivo, se gli incentivi sono corretti. Al contrario – dice Pietro Migliaccio, presidente della società italiana di scienza dell’alimentazione e sostenitore della campagna Coop – l’acqua potabile «arriva da acquedotti mediamente ottimi». Cioè, in prima approssimazione, metà sono sopra la media, ma l’altra metà sono sotto. Tant’è che, dopo nove anni di deroghe, ancora oggi un centinaio di acquedotti, pari a un rubinetto su sette, superano i parametri tossicologici richiesti dalle norme comunitarie. Almeno in questi casi, la scelta non è indifferente, e non riguarda solo l’incompatibilità (presunta) tra egoismo individuale e bene del pianeta. Almeno qui, l’informazione dovrebbe essere completa e specifica, non lasciata ostaggio della demagogia idrica. La libertà di bere quel che ci pare e piace è di per sé un argomento sufficiente. Specie quando coincide col diritto di stare bene.
A prima vista, si tratta di uno scontro anomalo. L’acqua in bottiglia non è in diretta competizione con quella del rubinetto. Le caratteristiche così diverse di questi due beni (a partire dal prezzo) lasciano intendere che intercettano domande differenti. La domanda vera, allora, è: cosa c’è dietro? Con 195 litri a testa, gli italiani sono i primi in Europa e i terzi al mondo (dopo i messicani e gli arabi degli Emirati) per consumo pro capite di minerale. Il confronto tra la principale catena di distribuzione e i produttori di acqua in bottiglia è, insomma, molto concreto. Coop spera di convincere i suoi clienti ad acquistare bottiglie a suo marchio, riempite presso fonti collocate in modo strategico per ridurre i costi di trasporto, ma stima un calo di vendite di circa il 10 per cento. Perché un’azienda dovrebbe consapevolmente perseguire una riduzione dei profitti?
La chiave sta nel presunto effetto reputazionale: e ciò a dispetto del reale fondamento di quella stessa comunicazione verde che, per quanti pregi possa avere, difficilmente riesce a ridurre argomenti complessi a un mero discrimine tra comportamenti buoni e cattivi. Del resto, le emissioni dovute a trasporto, produzione e smaltimento delle bottiglie sono una quota minima del totale. L’estrazione dell’acqua dal sottosuolo è strettamente regolamentata proprio per garantire la conservazione delle falde. Non siamo, insomma, di fronte a quella devastazione che uno si aspetterebbe. Perfino sul fronte sanitario, l’acqua minerale deve rispettare criteri rigidissimi: o è pura, oppure non può essere venduta, punto. Ne segue, tra l’altro, che i produttori tendono a vigilare per prevenire, o scongiurare, qualunque forma di infiltrazione o inquinamento.
È un classico esempio di come l’interesse privato possa allinearsi all’interesse collettivo, se gli incentivi sono corretti. Al contrario – dice Pietro Migliaccio, presidente della società italiana di scienza dell’alimentazione e sostenitore della campagna Coop – l’acqua potabile «arriva da acquedotti mediamente ottimi». Cioè, in prima approssimazione, metà sono sopra la media, ma l’altra metà sono sotto. Tant’è che, dopo nove anni di deroghe, ancora oggi un centinaio di acquedotti, pari a un rubinetto su sette, superano i parametri tossicologici richiesti dalle norme comunitarie. Almeno in questi casi, la scelta non è indifferente, e non riguarda solo l’incompatibilità (presunta) tra egoismo individuale e bene del pianeta. Almeno qui, l’informazione dovrebbe essere completa e specifica, non lasciata ostaggio della demagogia idrica. La libertà di bere quel che ci pare e piace è di per sé un argomento sufficiente. Specie quando coincide col diritto di stare bene.





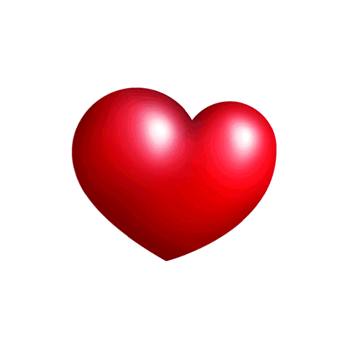

Nessun commento:
Posta un commento